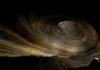Partecipare ad un evento come la vernice della Biennale d’Arte pone prima di tutto alcuni problemi di natura fisica, quali: reggersi sulle proprie gambe per 24 ore filate tra gradini in pietra d’Istria, fondamenta tendenti ad infinito, padiglioni dislocati nell’iperspazio e horror vacui di calli e campielli, affollati ma comunque preferibili al girone dantesco degli imbarcaderi dei vaporetti. In secondo luogo, e solo previo certificato di idoneità per attività agonistica, subentrano quelli di natura economica, come pernottare un numero ragionevole di giorni senza doversi trovare un secondo lavoro per ammortizzare le spese, e strategica, come cercare di vedere il numero più alto possibile di eventi, opere e persone nei tre giorni che vi sono fatalmente concessi. Infine, soltanto dopo aver considerato accuratamente tutte le istanze precedenti, si affacciano anche alcune problematiche di natura etica, riassumibili tutte in un laconico: ma in fondo chi me lo fa fare? Eppure si sa, dove si arena la ragione è la passione a muovere le montagne.
 Mladen Stilinović, Artist at Work, 1978 – 1983
Mladen Stilinović, Artist at Work, 1978 – 1983
Superati quindi questi ostacoli ed essendo riusciti a farsi largo più o meno brillantemente tra buffet e installazioni, finalmente arriva il momento peggiore: quello di recensire questo mostro a tre teste, questa specie di eruzione lavica che cola fino agli estremi più reconditi della laguna, replicandosi in una bulimia di appuntamenti ugualmente imperdibili; è questo di solito il momento in cui le variabili di cui sopra tornano impietose a chiedere il conto di una pausa troppo lunga per riposare i calcagni, o di un bicchiere di troppo di Bellini.
Eppure, nonostante tutto questo, come si fa a resistere ad una Biennale d’Arte interamente dedicata agli artisti, degli artisti e con gli artisti e intitolata per giunta Viva Arte Viva? Una scelta che ammetto all’inizio mi è sembrata un po’ troppo facile, ma che poi a furia di girarmela in testa è diventata in qualche modo irresistibilmente romantica. Una volta approdata tra i tigli dei Giardini, tra signore agghindate in modi improbabili che sfilavano sotto un temporale imminente, fotografi coperti di reflex come alberi di Natale, strette di mano, coppie che davano significato all’ombra in un lavoro che non ne ha, volantini svolazzanti, i neon chiassosi del Padiglione della Corea, i latrati dei dobermann al Padiglione tedesco e l’odore di muffa di quello di Israele, le note stranianti del redivivo Merzbau della Francia e le papere di plastica di quello della Repubblica Ceca, insomma, una volta sperimentato tutto questo, l’unica cosa realmente romantica come al solito è rimasta Venezia vista dal canale.
 Franz West, veduta della mostra, Giardini, Padiglione Centrale
Franz West, veduta della mostra, Giardini, Padiglione CentraleDopo essermi riempita gli occhi del tipico altalenarsi lagunare tra kitsch e lirismo, tornata sulla terraferma ho constatato che Viva Arte Viva non è stata molto apprezzata nemmeno dalla stampa estera, che ha scagliato la prima pietra contro la sua scarsa aderenza con l’attualità politica in un momento storico in cui l’attualità politica sembra davvero colarci addosso da tutte le parti. E certo da questo punto di vista, paragonata alla scorsa politicizzatissima edizione del collega Okwui Enwezor, questa 57esima ha un po’ il gusto del caffè annacquato: qualcosa che vorresti prendere per svegliarti ma invece ti lascia in bocca soltanto un senso di nostalgia.
Eppure la critica che farei io ora, da sopravvissuta, non è tanto sulla scelta del tema; il tema in fondo sembra collocarsi al momento giusto, fatalmente in concomitanza con le polemiche suscitate dal libro Attacco all’Arte di Simona Maggiorelli, che con un’invettiva evergreen di janclairiana memoria accusa l’arte contemporanea di complottismo, come un prodotto storto ad uso e consumo del mercato finanziario; bello senz’anima, si potrebbe dire, e talvolta nemmeno quello. In quest’ambito di sospetto generalizzato, che allunga i suoi tentacoli non solo in Italia, riportare al centro il mondo creativo dell’artista, la sua ricerca, il suo essere individuo e non quota azionaria e ridare rilievo al ruolo cruciale, sciamanico perfino, che ricopre all’interno della società non è certo una cattiva idea. Quello che manca forse, è una presa di posizione. Merito di una precisa volontà di prendere le distanze dalla figura del curatore autoriale o di una debolezza endemica del progetto? Un sassolino che forse mi resterà sempre nella scarpa.

Viktor Vorobyev e Yelena Vorobyeva, The Artist is asleep, 1996
Tralasciando questi cavilli non resta che analizzare il nuovo umanesimo professato dal direttore artistico Christine Macel, tastare il polso della situazione e capire, attraverso le opere proposte, qual è l’immagine dell’artista contemporaneo che viene profilata da questa Biennale, e cosa è chiamato a fare come garante del nuovo sistema. La risposta a questa domanda l’ha già data la curatrice stessa in decine e decine di interviste: cosa fa oggi l’artista per l’umanità? Resiste. Fa da interprete e amuleto contro le forze oscure che minacciano la nostra civiltà, si immola per la causa; con la sua azione veggente e salvifica esorcizza e ci libera, ampliando le nostre prospettive. Questo, secondo Macel, ci dicono gli artisti di tutte le generazioni, 120 per l’esattezza, tra misconosciuti e nuove proposte, la maggior parte alla prima esperienza con la salsedine lagunare, che sono diluiti in quello che vuole essere un viaggio scandito da nove stazioni-padiglioni transnazionali e ordinati secondo le logiche di un percorso che parte dalla mente dell’artista e si conclude con la percezione finale e soggettiva della loro opera da parte del pubblico.

Ciprian Mureşan, veduta dell’installazione, Giardini, Padiglione Centrale
Si comincia ai Giardini con il Padiglione degli Artisti e dei Libri, che riesuma dalle catacombe il tema dell’otium caro agli antichi per ridargli una nuova doverosa centralità a discapito del negotium oggi imperante. Nella società attuale tutta volta all’iperproduttività la reputazione dell’otium è decisamente virata verso la nullafacenza, ma Macel ci tiene a mettere i puntini sulle i e sottolinea che è proprio l’otium ciò che distingue il lavoro artistico da tutti gli altri. Il fatto che l’artista per produrre abbia bisogno di crearsi attorno una zona franca, uterina, in cui isolarsi e riflettere per farsi poi cassa di risonanza della coscienza, spesso sporca, del mondo. A differenza del tempo per se stessi che interviene a spezzare la routine dei comuni lavoratori, che si configura come distrazione e intrattenimento, non di rado accompagnato da un senso di colpevolezza, quello necessario al creativo è strutturale, è parte integrante della sua produzione.
Come venga affrontato lo mostrano dieci fotografie in bianco e nero dell’artista concettuale Mladen Stilinović, che lo raffigurano dormiente su un divano letto sotto il titolo Artist at work e aprono in grande stile l’intera esposizione. A fargli eco Franz West, il quale, dopo aver esposto una estroversione del suo studio durante la Biennale del 2011, porta in mostra il suo divano, a dire il vero vagamente simile al lettino di uno psicanalista, e una fotografia che lo ritrae pigramente reclinato sui cuscini. La chaise longue in questo caso non è un object trouvé, ma un pezzo concepito dall’artista stesso per ospitare il cruciale momento del riposo e della meditazione, componente essenziale del processo creativo. Gli fanno eco Viktor Vorobyev e Yelena Vorobyeva con The Artist is asleep, un’installazione ad effetto che celebra il dolce far nulla come ingrediente segreto dell’arte viva. Leggermente diverso il concetto di otium di Down Kasper che trasferisce il proprio studio nello stesso padiglione mostrando al mondo come la sua attività principale sia perdere tempo, suonare qualche strumento e chiacchierare con i visitatori. Katherine Nunez e Issay Rodriguez invece, riproducono uno studio sommerso da rotoli e scartoffie in tessuto, manufatti creati da loro stesse e sfogliabili dai visitatori, introducendo un altro aspetto fondamentale di questa improduttività apparente, quello della lettura e della ricerca.

Firenze Lai, Shoulder Pain, 2012
Si apre quindi il primo momento confortante dell’esposizione, in cui la curatrice rassicura il pubblico sul rapporto costante dell’artista con la parola scritta e la storia dell’arte, anche nei tempi bui della post-verità. Un buon esempio di come sia viscerale questa assimilazione è l’attività di John Latham, celebre per aver dato fuoco all’Enciclopedia Britannica e per aver fatto masticare le pagine del saggio Art and Culture di Clement Greenberg, una pietra miliare nella trattazione del modernismo americano, ai suoi studenti, per poi distillare questa poltiglia in provetta; in mostra troviamo i suoi assemblages fatti di libri smangiati, gesso e pittura, concepiti all’insegna del motto “painting is an open book”. La forte personalità di Latham non toglie comunque spazio anche a forme meno nichiliste di amore per la lettura come La mia biblioteca, uno degli interessanti progetti collaterali di questa Biennale in cui la curatrice ha invitato ogni partecipante a donare all’archivio della manifestazione i libri per lui più significativi. Un sapere che l’artista quindi non consuma soltanto ma custodisce a qualsiasi costo, come mostra il video di Taus Makhacheva, in cui un funambolo della regione russa del Daghestan trasporta una serie di quadri a olio della tradizione da una cima all’altra di una montagna, usandoli come contrappeso per non sbilanciarsi e cadere nel vuoto. Tightrope, questo il nome dell’opera, vuole rendere conto del delicato ruolo di tramite della memoria e dell’equilibrio precario in cui oggi vive l’artista, sospeso tra vita reale e attività creativa. Di tutt’altro avviso sembra Ciprian Mureşan che invece ha passato la vita a riprodurre a matita i capolavori della storia dell’arte per poi ridurli a brandelli e gettarli nel cestino. A minare le sicurezze date dai libri e dal sapere tramandato sopravvengono tutte le incertezze della modernità: disuguaglianze, guerre, millantate catastrofi naturali che hanno costretto l’uomo a staccarsi dall’immagine di specie dominante e a confrontarsi anche con pulsioni meno nobili come l’ansia e il terrore dell’estinzione.

Marwan, Untitled, 1966
In successione organica rispetto a quello degli Artisti e dei Libri ecco quindi il Padiglione delle Gioie e Delle Paure, che riprende il brillante studio di Antonio Damasio sulla centralità delle emozioni nella definizione dell’identità umana, campo in cui gli artisti sono storicamente in grado di primeggiare, per farne una cifra distintiva del nuovo umanesimo. Immergendosi dentro sé stessi nell’immanenza dello spazio interiore, gli artisti si fanno interpreti di questo clima incerto e potenziali garanti della sopravvivenza dell’intera specie. Il padiglione vuole quindi descrivere il rimescolamento emotivo dell’animo dell’artista nella lotta contro queste forze, conscio più degli altri del nuovo profilo dell’essere umano, non più domatore ma bestia da soma. A contatto con questa nuova consapevolezza il volto di Tibor Hajas si sfalda strato per strato, mentre quello di Marwan assume le fattezze di un’icona cristologica frammentata e distorta. Dal disfacimento non è esente nemmeno il corpo, come dimostrano le dissezioni ossessive di Lubos PIny, o le sproporzioni claustrofobiche di Firenze Lai, con figure schiacciate e appiattite in uno spazio pittorico silenzioso come non mai. Considerato quindi tutto questo percorso, l’immagine più romantica dell’artista, e anche del visitatore, di questa Biennale 2017 l’ha data Suspension di Sebastian Diaz Morales, un video che con un’estetica sci-fi rappresenta un uomo sospeso nel tempo e nello spazio, fluttuante su un cosmo vastissimo, un’immensità fisicamente impossibile da padroneggiare o comprendere nella sua interezza.
Federica Fontana