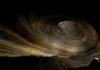L’Inferno è la Cantica forse più letta e apprezzata della Commedia. Spesso, però, sfugge uno dei motivi che la rendono una sorta di capolavoro nel capolavoro: la capacità del poeta di comprendere le innumerevoli pieghe dell’animo umano, sintetizzando importanti intuizioni in alcune memorabili parole. L’orrifica sfilata dei dannati serve a mostrare al lettore non solo e non tanto la destinazione ultraterrena di chi s’imprigiona per la vita in questa o quella forma di peccaminosità – ma soprattutto il senso sottile, e assieme assai concreto, psicologico ed etico, degli stessi peccati.
In questo, il poema di Dante prelude alla sensibilità moderna dei grandi romanzieri da Cervantes a Dostoevskij, ossia quell’arte della prosa che, esplorando le passioni e le relazioni, descrive una dura verità: gli uomini, per lo più, seguono dinamiche di vanità e rivalità, menzogna e potere, vivendo già in questa vita terrena una contro-socialità quasi infernale.
Nell’Inferno si trovano diversi esempi di questo, ma uno è particolarmente interessante, giacché testimonia la sottigliezza e precisione del ‘pensiero romanzesco in versi’ di Dante. Si tratta della vicenda di Pier delle Vigne (o della Vigna), il giurista capuano che divenne consigliere privilegiato di Federico II di Svevia e si suicidò dopo l’accusa di tradimento. Nell’interpretazione dantesca, Pier delle Vigne è stato calunniato dagli altri cortigiani, invidiosi del suo potere, fino a convincere l’Imperatore della sua infedeltà. Come è tipico di chi è accusato ingiustamente e patisce un’onta sociale pressoché totale, Pier delle Vigne non regge e si toglie la vita.
Eppure (a prescindere dalla liceità morale o meno del suicidio in sé), costui è davvero tanto innocente? Per quanto (nella versione di Dante) non sia vero che abbia tradito il suo signore, le parole che il poeta gli mette in bocca sono indicative di una sfrenata ambizione, della volontà di essere il solo e l’unico a contare, nella corte federiciana, in una sorta di opera di seduzione del sovrano (“… sì soavi / che dal secreto suo quasi ogn’uomo tolsi”).
Tale comportamento è già peccaminoso, e inevitabilmente suscita la reazione maligna in quelli che, estromessi a priori come collaboratori, alleati, pari, si scatenano nel loro ruolo latente di rivali e nemici – e così trionfa la “morte comune”, “de le corti vizio”, la “meretrice” Invidia, sempre in agguato nei luoghi del potere. In questa prospettiva, il suicidio rimanda allo smarrimento morale di un uomo che punta tutto sulla potenza mondana, e che, una volta perdutala, non ha più alcuna ragione di vita: è come se Pier delle Vigne sacrificasse il suo corpo e la sua anima a un’idolatria terrena. Ma allora il suicidio si rivela un esito coerente con uno sviamento fondamentale, ben precedente, costruito giorno dopo giorno.
Segue l’immaginifica descrizione del contrappasso per i suicidi: dopo la morte, le loro anime si trasformano in piante selvatiche, sterpaglie dai rami contorti, nuove membra, martoriate dalle arpie, mostruosi uccelli della mitologia greca. Nel Giorno del Giudizio, questi dannati riavranno i loro corpi, senza però potersene rivestire, “ché non è giusto aver ciò ch’om si toglie”: rimarranno appesi agli alberi, per l’eternità.
Commedia, Inferno, Canto XIII, vv. 58-78 e 94-108.
Io son colui che tenni ambo le chiavi
del cor di Federigo, e che le volsi,
serrando e diserrando, sì soavi,
che dal secreto suo quasi ogn’uom tolsi;
fede portai al glorïoso offizio,
tanto ch’i’ ne perde’ li sonni e ’ polsi.
La meretrice che mai da l’ospizio
di Cesare non torse li occhi putti,
morte comune e de le corti vizio,
infiammò contra me li animi tutti;
e li ’nfiammati infiammar sì Augusto,
che ’ lieti onor tornaro in tristi lutti.
L’animo mio, per disdegnoso gusto,
credendo col morir fuggir disdegno,
ingiusto fece me contra me giusto.
Per le nove radici d’esto legno
vi giuro che già mai non ruppi fede
al mio segnor, che fu d’onor sì degno.
E se di voi alcun nel mondo riede,
conforti la memoria mia, che giace
ancor del colpo che ’nvidia le diede”.
[…]
Quando si parte l’anima feroce
dal corpo ond’ella stessa s’è disvelta,
Minòs la manda a la settima foce.
Cade in la selva, e non l’è parte scelta;
ma là dove fortuna la balestra,
quivi germoglia come gran di spelta.
Surge in vermena e in pianta silvestra:
l’Arpie, pascendo poi de le sue foglie,
fanno dolore, e al dolor fenestra.
Come l’altre verrem per nostre spoglie,
ma non però ch’alcuna sen rivesta,
ché non è giusto aver ciò ch’om si toglie.
Qui le strascineremo, e per la mesta
selva saranno i nostri corpi appesi,
ciascuno al prun de l’ombra sua molesta”.