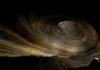“Egoista (s.m.). Persona priva di considerazione per l’egoismo altrui.”: così scriveva Ambrose Bierce, e non avrebbe mai potuto immaginare che Andrey Zvyagintsev, nel 2017 e tre anni dopo lo splendido Leviathan, avrebbe fatto di quella citazione la testata d’angolo del suo ultimo film, Нелюбовь (Neljubov’, Loveless). Il regista russo mette in scena un dramma familiare tremendo, eppure possibile, possibilissmo: Ženja e Boris stanno vivendo in modo traumatico la fine del loro matrimonio, mentre annegano nella palude del divorzio, dediti a salvare soltanto loro stessi, la loro apparenza e l’illusione della felicità che li attende alla fine del travaglio; una nuova vita con un 47enne divorziato e benestante lei, con una giovane ragazza insicura lui. Nel mezzo di questo pantano, il figlio 12enne Alyosha, creatura mai amata e zavorra che impedisce loro di concentrarsi verso la nuova fase della vita. L’ennesima discussione fra i due, riguardante proprio il destino di quel figlio ripudiato, viene da quest’ultimo colta in segreto: già segnato dalla totale disaffezione dei genitori, questo rappresenta per lui il colpo di grazia. E Zvyagintsev ce lo comunica con un pugno nello stomaco: telecamera fissa sul pianto silenzioso del bambino, prima nascosto dietro la porta che dà sulla cucina, che viene poi chiusa dalla madre ignara della sua presenza. Qui il contrasto glaciale, devastante di quegli occhi azzurri distrutti da lacrime mute mentre le urla all’interno si alzano ovattate, i genitori impegnati a sbranarsi cercando di scaricare l’uno sull’altro quel fardello, è marcatissimo. Ženja ad ogni occasione utile ricorda di non aver mai voluto quel bambino (lo vomiterà in faccia all’ex-marito in almeno tre occasioni, ed alla parrucchiera nel salone di bellezza, arrivando all’apice della bassezza nel ricordo di quanto il parto la fece penare: come se il parto, per le altre donne, fosse una passeggiata di salute), reclama il diritto a rifarsi una vita senza il peso di un figlio che potrebbe logorare la nuova relazione, mentre Boris non è disposto ad assumersi la responsabilità di occuparsi di Alyosha, essendo la sua attuale compagna in attesa di un figlio. Il regista racconta le genesi del disastro con sapienza, lasciando alla madre il doloroso compito di urlare la verità: quel figlio era stato, dodici anni prima, il passaporto con cui Ženja era potuta fuggire dalla madre, una tiranna oppressiva divorata ora dalla solitudine, che si trincera dietro a noiose frasi fatte come “Dio mi è testimone” mentre allontana la figlia, cercando invece di comunicarle la sofferenza della solitudine (le brevi ma incisive inquadrature della casa della donna fanno il resto: un cancello di lamiera eretto a muraglia, luci volutamente spente per non farsi notare dall’esterno, ninnoli religiosi e polvere sedimentata ovunque). E ci si sente come intrusi, nei due minuti che Zvyagintsev dedica alla tana di questo essere singolare: un’occhiata e via, si è portati a pensare, tanto è il disagio che l’intero quadro provoca. I protagonisti scapperanno mentre l’anziana insiste nello sciorinare, ormai solo a se stessa, la sue vane e noiose pillole di saggezza. Tutta l’angoscia di un’esistenza che va dissolvendosi, facendosi fantasma mentre il ricordo dell’essere fisico sparisce. Ženja e Boris la ricorderanno soltanto mentre ne fanno una descrizione non di certo lusinghiera. Ottenuta la libertà, la stolta foga giovanile che era stata equivocata (con delatoria leggerezza, invero) per amore si era presto dissolta – “Voi non potete immaginare ciò che un giovane inesperto, educato alla maniera sbagliata, può scambiare per amore!” sentenzia Turgenev in “Un nido di nobili”: per dare la cifra di quale trappola possa rappresentare la dimensione aritocratica e borghese russa, immobile ora com’era nell’Ottocento – inaridendo irrimediabilmente il territorio comune e mostrando la vera natura di entrambi gli sposi. Non sorprende che sia l’apparenza a farla da padrona nelle vite di entrambi: apparenza che è diretta compagnia dell’egoismo più infantile. La sapienza di Zvyagintsev sta nel guidare lo spettatore in modo diretto durante il percorso dissimile che porta i due allo stesso svilente risultato: mentre Ženja vive con lo smartphone sempre a portata di mano, costantemente asservita ai social network, impegnata a fotografarsi mentre sorride ed a fotografare il cibo di un ristorante elegante in cui cena col nuovo compagno (mentre un gruppo di ragazze, nel tavolo a fianco, scatta un selfie d’ordinanza condito da sorrisi superficiali e fasulli), Boris ha come unica preoccupazione quella di mantenere il posto di lavoro: il suo dirigente infatti è un ortodosso conservatore di ferro, e pretende che tutti i suoi dipendenti abbiano una famiglia stabile (memorabile è il colloquio che proprio Boris ha con un suo collega, al quale appunto chiede lumi sulla politica aziendale in materia famigliare: questi, invece di fugare i suoi dubbi e tranquillizzarlo, gli rivelerà che addirittura un suo conoscente, per non perdere il posto, aveva con tutta probabilità pagato una donna e due ragazze affinché fingessero di essere la sua famiglia. E mentre Boris mastica con volto da automa guardando in camera, il collega rincorre beato con la forchetta la verdura uscitagli dal piatto, chino sul tavolo e disinteressato). Dopo aver dedicato due scene alla nuova intimità che i due protagonisti credono di aver scoperto con i rispettivi nuovi amanti – rigorosamente a camera fissa, da un’altra stanza che non sia quella in cui si consuma l’atto, mentre il crepuscolo prende lentamente il sopravvento senza che una luce artificiale convincente si accenda a far chiarezza: non c’è delicatezza, soltanto l’esigenza di riscuotere un piacere dovuto, come ricompensa per le tribolazioni passate negli anni precedenti, al culmine di un egoismo infantile e ridicolo scambiato per felicità vera; mentre Boris si spoglierà silenziosamente, agendo quasi meccanicamente, come se fosse un obbligo morale (esiste egoismo più stolido?) Ženja ribadirà più volte al compagno di amarlo, aspettando invano che questi ricambi a voce mentre lei racconta la sua vita devastata dall’infelicità mentre lui, maturo e comprensivo, la abbraccia donandole quel conforto cheto e tacito che lei non può comprendere, concentrata su se stessa (così adolescenziale da risultare quasi commovente) e sull’amore che merita – ecco deflagrare silenziosamente la bomba che spezza la pellicola in due: Ženja, rientrata a tarda notte ed infilatasi subito a letto (dopo aver sorriso, ovviamente, allo schermo del suo smartphone che portava la buonanotte del compagno), si accorge soltanto la mattina successiva che il figlio non è rientrato a casa, il giorno precedente. E se ne accorge (come se già il fatto in sé non fosse drammaticamente vergognoso) grazie ad una chiamata della professoressa di Alyosha, la quale chiede come stia il ragazzino, che non si presenta a scuola ormai da due giorni. Presa da un panico difficilmente inquadrabile (grandiosa Maryana Spivak in questa sequenza, capace di mostrare un’ampia gamma di contraddizioni nell’arco di un secondo, con una mimica facciale straordinaria), ella contatta immediatamente Boris, che si mostra quasi indifferente, non assecondando i timori dell’ex-moglie, occupato in realtà a starsene inchiodato al lavoro (quanto sangue gli costerà, il giorno successivo, chiedere un giorno di permesso).
Da questo momento in poi, ovvero da quando il figlio viene considerato scomparso, Zvyagintsev cambia registro e si focalizza sui dettagli: se fino ad ora la critica del regista ad una società superficiale e sclerotizzata era evidente, quasi ossessiva, nella seconda metà il film poggia su indizi impliciti, inseguendo le ricerche del ragazzino scomparso con lunghi piani sequenza, dialoghi brevi, serrati e concitati che spostano in secondo piano gli intrecciati egoismi dei protagonisti (unica, splendida eccezione è il breve monologo a cui Ženja si abbandona, al limite della frustrazione, in macchina accanto a Boris). L’assoluta priorità è ora quella di ritrovare Alyosha, ma la frenesia è appunto tutta dialogica: il movimento è quasi pigro, attutito, anche se continuo – la parte delle indagini che si svolge nel bosco è girata da un’angolatura tale che i volontari della squadra di ricerca sembrano una colonia di formiche ben compatta alla ricerca di cibo, anche se ben visibili nei loro giubbetti catarifrangenti. Di questa lentezza risentono (non necessariamente in una connotazione negativa) anche i protagonisti: tutto viene congelato, il confronto su chi sia più egoista, le relazioni instaurate dopo il fallimento del matrimonio. L’incredulità di Ženja di fronte al poliziotto che la avverte degli ostacoli burocratici che attendono la famiglia per ritrovare il figlio è la cifra stilistica di quanto l’ingranaggio Civiltà possa stritolare le priorità di ogni essere umano che vive al suo interno. Sarà infatti la squadra di volontari di ricerca a mostrare il lato empatico della società, in maniera comunque sempre formale. Ed è qui che davvero Zvyagintsev svela la propria intima, disperata chiave di lettura: la scomparsa scompiglia le carte sul tavolo, ma fondamentalmente non riesce a scuotere il torpore in cui i protagonisti sono ormai scivolati. Boris rimarrà assurdamente apatico, lo sguardo perso mentre la vita gli scorre addosso (soltanto in una scena precisa, diretta, cruda, si lascerà andare ad un pianto ambiguo, a metà fra la disperazione scatenata dall’essere inerme di fronte ad una situazione che vorrebbe scrollarlo con violenza e la rabbia per il dover rivedere la sue più immediate priorità), mentre Ženja avrà uno scatto insperato (ma quanto sentito, quanto veritiero?), salvo poi sprofondare nuovamente nell’irrealtà che ella si è testardamente fabbricata attorno. Soltanto ora il fantasma di Alyosha può perdersi, ovunque: che sia in un oscuro viottolo, in una notte di tenebra nevosa (su cui il regista indugia, quasi volesse invitarci a scoprire un segreto lì custodito dall’angoscia) – mentre accanto la madre e il compagno appiccicano meccanicamente manifesti di scomparsa ad ogni lampione, o sopra un’alba polverosa, accanto ad un’ombra solitaria in attesa di un bus anonimo.
La casa in cui i protagonisti hanno lacerato la loro relazione, in vendita all’inizio del film, è stata finalmente acquistata. Lo scorrimento orizzontale della camera, che ipnoticamente sbircia da sinistra a destra, mostra una squadra di operai nel pieno dei lavori di ristrutturazione: non c’è più traccia della camera del ragazzino – a Zvyagintsev preme ribadire l’assenza fisica di Alyosha, ma è ancora possibile scorgere, fra l’urlo di un trapano e quello di un operaio, il sibilo del suo spirito – e dove una volta si trovava il divano su cui Boris era confinato durante la notte, ora fa capolino un letto a castello che ospita momentaneamente i lavoratori. Così si congeda il figlio scomparso, silenziosamente (e risulta evidente, ora, il marcato contrasto fra le strilla vuote dei genitori e il suo malinconico mutismo: trafitto e violato dall’egoismo sfrenato di chi avrebbe dovuto amarlo, fluttua ora come uno spirito shakespeariano bloccato in questa dimensione, quieto torturatore delle anime di chi l’ha distrutto mentre avrebbe dovuto proteggerlo). Mentre in sottofondo la televisione ci rimanda l’eco del terribile conflitto civile ucraino – il 2012 della presunta fine del mondo sfiora appena le orecchie da mercante dei protagonisti – Boris osserva con occhio vitreo il bambino nato dalla sua nuova relazione mentre l’attuale compagna, parlando con la madre che le prospetta un cambio di residenza per ampliare l’angusto spazio in cui vivono, lascia intuire che proprio dall’uomo non arriva una risposta precisa. Boris non vive, è consumato da un’abulia totale. E così Ženja, intenta a correre su un tapis roulant sotto la neve, lo sgurado prosciugato di qualsiasi emozione fisso avanti a sé. Ora sono entrambi sterili: della loro eredità, non è rimasto che un nastro bicolore ancorato ad un ramo, ultima traccia di un figlio mai desiderato e che per loro, ogni giorno, raramente è esistito (sommesso, un tocco di pianoforte è lì a ricordarcelo). Chi ha sofferto di più? Chi ha colto, da questo dramma familiare, l’occasione di fiorire e vivere fuori dall’illusione di essere il centro del mondo? Sono domande che distillano, ancora una volta e per sempre, veleno d’egoismo. È il dramma del dettaglio che diventa affresco universale. La speranza è l’ultima a morire, si dice: Zvyagintsev l’ha uccisa con uno sguardo crudo, grigio: non ci sono sopravvissuti.
Mattia Orizio