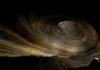Fortunatamente, ci sono parole per tutto. Fortunatamente ne esistono alcune che non dimenticano di raccomandarci che chi dà deve dare con entrambe le mani perché in nessuna delle due rimanga quel che dovrebbe appartenere ad altre. Come la bontà non ha da vergognarsi di essere bontà, anche la giustizia non dovrà dimenticare di essere, innanzitutto, restituzione, restituzione di diritti. Tutti, a cominciare dal diritto elementare di vivere degnamente. Se mi dicessero di disporre in ordine di precedenza la carità, la giustizia e la bontà, metterei al primo posto la bontà, al secondo la giustizia e al terzo la carità. Perché la bontà, da sola, già dispensa la giustizia e la carità, perché la giustizia giusta già contiene in sé sufficiente carità. La carità è ciò che resta quando non c’è bontà né giustizia.
(José Saramago – Il quaderno)
Sarebbe fin troppo semplice parlare dell’ultimo romanzo di Davide Enia come di un libro sugli sbarchi a Lampedusa; è giusto, in parte lo è sicuramente. Ma liquidarlo in fretta vorrebbe dire essersi fermati all’increspatura dell’acqua, laddove i cadaveri di poveri cristi restano a galleggiare. Quelli che si vedono, almeno.
Invece non è solo così. Immergendosi di più, nel fondo del fondo, c’è un cimitero marino di uomini, memoria e innocenza per sempre perduti e che l’autore prova a fotografare, come suo padre prova a catturare nella rete visiva una immagine, un senso in questa immagine, un’increspatura (anche qui) della superficie, ma necessaria in quanto possibilità di un’altra cosa; che sia l’immagine a parlare per sé stessa e al di là di essa, così come la scrittura mentre si dispiega, o lo spazio tra le righe: quel bianco, quel vuoto che sa di smottamento sotto i piedi, di naufragio. O di memoria. Per andare più a fondo, nel fondo, nella processione di volti ed esperienze di cui il libro è costellato.
Il linguaggio privilegiato di Enia è sempre quello del ricordo, come nei suoi lavori precedenti, ma qui inevitabilmente con meno ironia. La memoria di partite di pallone, delle prime nuotate e dei ricordi d’infanzia deve lasciare spazio a una mattanza di uomini, donne e bambini, al guasto della cancrena in corso di un tessuto umano sempre più vicino allo strappo, del tutto fuori controllo, non fosse per quei pochi che provano a darne testimonianza e resistere, far resistere.
La lingua del ricordo e del presente, quindi, usata in un racconto familiare dove trovano posto i rapporti tra padre e figlio, quello tra il figlio e l’amatissimo zio Beppe, e tra fratelli. Fratelli di sangue da una parte, fratelli naufraghi dall’altra. La forza del libro sta proprio nella sua schiettezza autobiografica, dove l’autore sa mettersi a nudo. Annie Ernaux o Thomas Bernhard lo fanno con spietata autoanalisi, arrivando al punto di sporcarsi quasi in maniera masochista; il percorso di Enia è invece molto più solare, nonostante tutto, forse perché lui per primo non parte con l’intenzione di parlare di sé ma di altri. Mentre di sé stesso parla, eccome. Ci pone di fronte l’impatto del dolore privato restituendolo a tutti. Arrivando al punto in cui quella che dovrebbe essere la tragedia che ci riguarda più da vicino (le centinaia di migliaia di migranti che affrontano un viaggio inaudito tra botte, stupri, umiliazioni e morte) diventa quasi una sorta di tremenda questione privata con cui affrontare il trauma dell’altra – la malattia dello zio Beppe. Entrambe le tragedie si parlano a distanza ravvicinata, si toccano e fondono in un unico shock collettivo. Una foto di samurai, guerrieri, calciatori che sanno perdere, forse hanno già perso, ma resistono, non si arrendono.
Sciascia parlava del ritratto fotografico come entelechia, ovvero di “una fotografia che fosse il centro, il luogo geometrico di un’esistenza; che dicesse, insomma, “la storia di un’anima”. Nella stessa riflessione citava Hofmannsthal. Riporterò la citazione aggiungendo una parola adatta al libro di Enia: “Un uomo che muore [annegato] a trentacinque anni è in ciascun punto della sua vita un uomo che morrà [annegato] a trentacinque anni”. Appunti per un naufragio è questa immagine netta, pulita e priva di fronzoli della tragedia vista come inevitabile una volta compiutasi.
Se ho parlato delle fotografie del padre dell’autore (Francesco Enia) non è solo per la pregnanza simbolica che serve da contraltare artistico alla scrittura del figlio – due medium da sempre in comunicazione, l’immagine e la parola – né perché ne campeggia una in copertina, con due figure stagliate su un molo (“C’è qualcosa di liturgico nel suo modo di fotografare”), ma perché il rapporto tra padre e figlio è un nucleo fondamentale degli Appunti. È un rapporto generazionale tipicamente siciliano in cui ci si deve sforzare di parlare perché aprirsi non è facile; ne dà conto l’autore in un paragrafo incredibilmente schietto, come solo gli scrittori siciliani sanno esserlo quando parlano di sé stessi, della loro gente, della loro isola rinchiusa in sé stessa e aperta a tutti allo stesso tempo.
“In meridione si sconta una difficoltà comunicativa figlia di una cultura secolare in cui tacere è sintomo di virilità.
«Omo di panza» è il modo lusinghiero per definire chi si presume abbia uno stomaco così forte da trattenere dentro tutto: i dubbi, i segreti, i traumi. E’ un tratto distintivo del paternalismo: il tacere diventa un’arte che si apprende fin da piccolissimi. Parlare è una attività da fìmmina. I deboli parlano, i veri màsculi stanno muti. La consegna del silenzio, soglia di quella rocca quasi inscalfibile che è l’omertà, è una conditio sine qua non per integrarsi. In ogni caso, giusto per mettere le cose in chiaro, ‘a megghiu parola è chìdda ca ‘un si dice.”
L’esperienza a Lampedusa porta entrambi a cercarsi come mai prima. A smantellare quell’arte da uomini: l’onore del silenzio.
Enia sa perfettamente che in futuro ci sarà una letteratura epica di Lampedusa, una epica che verrà al mondo quando a parlare saranno i migranti: lo scrive in modo esplicito. Ma questo suo romanzo è pur sempre una storia mediterranea. Forse senza volerlo questi appunti sono tali perché vogliono sottrarsi con umiltà nel prendere troppo spazio alle testimonianze collettive di chi riesce a sbarcare, e allo stesso tempo dichiarano l’impossibilità di un’epica dal punto di vista “nostro”, quantomeno per Lampedusa, terra di frontiera immaginifica e concreta, di cui tutti parlano e nessuno pare conoscerla davvero; un microcosmo di confine come poteva esserlo quello di Derek Walcott, capace di rimpastare Omero e immaginario creolo. Eppure brandelli di epica vengono sospinti dalla risacca di questo mare, lo stesso che ha visto i vagabondaggi di Ulisse nel ritorno a casa verso Telemaco. Si potrebbero tirare in ballo Borges e le sue quattro storie ricorrenti: dire quindi che non è una questione di Mediterraneo e di luoghi, bensì di tòpoi letterari/mitologici a cui tutti i successori si rifanno, volenti o nolenti. Eppure io credo che sia questo mare a cantare sempre la stessa canzone, basta non avere palpebre all’orecchio per ascoltarla. Sono brandelli di epica, certo, perché noi, ripeto con Enia, non possiamo farne un’epica. Possiamo al massimo dare una testimonianza, ora e qui, tendere mani come ponti, accogliere e, quando riusciamo, salvare. Come il sub che deve decidersi sul momento in una spietata economia della sopravvivenza: salvare dalla morte certa tre persone o una ragazza con il suo bambino? Come si può anche solo immaginare una domanda del genere? Questi dubbi amletici sono materia di filosofia morale per noi comodi a casa, in treno, all’università, in cucina, seduti a immaginarcele, ma saranno attimi di angoscia per chi deve intervenire sul momento e tempo di pensarci non ne ha. Con la consapevolezza tremenda dell’inevitabile: qualunque cosa sceglierai ti segnerà a vita.
Arrivando al succo della questione: questo è un libro di fantasmi. Parla di un naufragio collettivo. L’angoscia arriva quando ti rendi conto che i fantasmi siamo noi vivi, scarnificati a poco a poco dell’umanità che ci restava, incapaci di affrontare il presente. Allora forse è bello ci siano momenti in cui una fiammella accesa diviene sinonimo di speranza.
«Lampedusa, da lepas, lo scoglio che scortica, eroso dalla furia degli elementi, che resiste e conferma una presenza, anche solitaria, nella smisurata vastità del mare aperto. Oppure, Lampedusa da lampas, la fiaccola che risplende nel buio, luce che sconfigge lo scuro.»
E sta a vedere che il romanzo più vicino a questo di Enia sia quello di un altro amante della frontiera e dell’estremo come l’americano Cormac McCarthy, che in Non è un paese per vecchi concludeva la sua storia di naufragio dei valori e di umanità con la stessa immagine della fiaccola, in un sogno. Ma questo di Davide Enia è “un sogno fatto in Sicilia”, sciascianamente parlando.