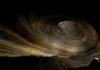“Guardate la mia architettura: mattoni di viscere, con un coltello per cazzuola”
(Alan Moore & Eddie Campbell – From Hell)
(Alan Moore & Eddie Campbell – From Hell)
Von Trier ha la rara capacità di essere antipatico quasi a tutti, persino a sé stesso, ma quando imbrocca il film difficile si riesca a dimenticare. E quest’ultimo La Casa di Jack (The House That Jack Built – il titolo è ripreso da una antica filastrocca) si pianta come un punteruolo nel cuore dello spettatore: impossibile rimanga indifferente.
E von Trier è sempre poco raffinato, non gliene frega nulla di esserlo; basti vedere alcuni indizi urlati ad alta voce: dal cric (in inglese “jack”) che sfonda la faccia di Uma Thurman e su cui il protagonista (Jack, ma va?) inizia a costruire il suo edificio di cadaveri, fino alla citazione tableaux vivant della barca dantesca dal celebre dipinto di Delacroix (che è anche uno dei poster del film), a volte la sensazione è che il regista danese stia esagerando – e come dimenticare la volpe parlante di Antichrist? E, per alcuni, TUTTO Antichrist? Ma qui sta il miracolo: von Trier riesce a prendere saldamente in mano le redini della discesa (a rotta di collo) nel cuore di tenebra del protagonista. E del suo cinema.
Riprendendo la forma-confessione già vista in Nymphomaniac, più la classica struttura a capitoli (con tanto di epilogo tra i più visionari visti negli ultimi anni), il film racconta la storia di un serial killer, tale Jack, un ingegnere che si definisce architetto e che per più di dieci anni sfida la polizia e sé stesso nella ricerca di nuove forme artistiche dell’assassinio. La sua continua progettazione di omicidi esteticamente impeccabili è l’ossessione ricorrente che lo tiene impegnato, ma non solo quella: altrettanto fondamentale è per Jack la progettazione di una casa (quella del titolo) su misura. Ora, Bachelard diceva che la casa è il simbolo del mondo interiore. Ma quale può essere l’interiorità di uno psicopatico? La casa di Jack non può che restare sempre vuota, insoddisfatta, allo stato larvale se la si immagina come una architettura fisica. Al contrario, sarà perfetta quando le fondamenta e le sue strutture portanti saranno fatte da cadaveri.
E von Trier è sempre poco raffinato, non gliene frega nulla di esserlo; basti vedere alcuni indizi urlati ad alta voce: dal cric (in inglese “jack”) che sfonda la faccia di Uma Thurman e su cui il protagonista (Jack, ma va?) inizia a costruire il suo edificio di cadaveri, fino alla citazione tableaux vivant della barca dantesca dal celebre dipinto di Delacroix (che è anche uno dei poster del film), a volte la sensazione è che il regista danese stia esagerando – e come dimenticare la volpe parlante di Antichrist? E, per alcuni, TUTTO Antichrist? Ma qui sta il miracolo: von Trier riesce a prendere saldamente in mano le redini della discesa (a rotta di collo) nel cuore di tenebra del protagonista. E del suo cinema.
Riprendendo la forma-confessione già vista in Nymphomaniac, più la classica struttura a capitoli (con tanto di epilogo tra i più visionari visti negli ultimi anni), il film racconta la storia di un serial killer, tale Jack, un ingegnere che si definisce architetto e che per più di dieci anni sfida la polizia e sé stesso nella ricerca di nuove forme artistiche dell’assassinio. La sua continua progettazione di omicidi esteticamente impeccabili è l’ossessione ricorrente che lo tiene impegnato, ma non solo quella: altrettanto fondamentale è per Jack la progettazione di una casa (quella del titolo) su misura. Ora, Bachelard diceva che la casa è il simbolo del mondo interiore. Ma quale può essere l’interiorità di uno psicopatico? La casa di Jack non può che restare sempre vuota, insoddisfatta, allo stato larvale se la si immagina come una architettura fisica. Al contrario, sarà perfetta quando le fondamenta e le sue strutture portanti saranno fatte da cadaveri.
Jack come il cric, Jack come il primo serial killer dell’era moderna, il più celebre Squartatore, anch’egli architetto ma nel senso massonico ed esoterico come lo concepì Alan Moore in From Hell. Le citazioni a Jack the Ripper si sprecano: dai cinque capitoli come le cinque prostitute accertate uccise dello squartatore, al seno tagliato a una delle vittime che il Jack di von Trier usa come borsellino, mentre lo squartatore di Moore come cuscino.
In una delle riflessioni di Guido Ceronetti ne Il silenzio del corpo, questi annota:
“È scritto in testi alchemici: «Apri il seno di tua madre con la lama d’acciaio e penetra fino alla matrice»”. Interessante, perché il film riflette molto sul ruolo della donna come vittima sacrificale perfetta (per l’assassino seriale, per il mondo), con punte di misoginia crudeli del protagonista (un uomo, nel cinema di von Trier non succedeva da un po’), e di indifferenza sociale nei confronti della vittima.
Ceronetti continua la sua riflessione sul taglio alchemico del seno della madre così: “Jack lo Squartatore lo ha fatto, alla lettera, pigliando come madri cinque (o sette?) disgraziate donne malandate e affamate, spinto da un bisogno indegnamente alchemico di frugare nella materia prima e nel caos universale. Non era un adepto; una discesa puramente simbolica nel cuore della materia non l’avrebbe attirato. Il parallelismo resta impressionante: quel che gli spirituali fanno figuratamente, in modo incruento, senza dare la morte però vivendola e assorbendola nel proprio essere, il misterioso assassino del 1888 ha compiuto per strade visibili, orribilmente, materialmente. Sopraffatto dalla nigredo ha cercato pace, alla fine, nelle acque nere di un fiume, ultima discesa nel caos. Anche il Black Cat di Poe può suggerire qualche immagine alla ripperologia metafisica: Jack apre i corpi per murarci il Gatto Nero che l’ossessiona; il gatto ancora miagola per le vie di Londra, nel silenzio dei corpi.”
In una delle riflessioni di Guido Ceronetti ne Il silenzio del corpo, questi annota:
“È scritto in testi alchemici: «Apri il seno di tua madre con la lama d’acciaio e penetra fino alla matrice»”. Interessante, perché il film riflette molto sul ruolo della donna come vittima sacrificale perfetta (per l’assassino seriale, per il mondo), con punte di misoginia crudeli del protagonista (un uomo, nel cinema di von Trier non succedeva da un po’), e di indifferenza sociale nei confronti della vittima.
Ceronetti continua la sua riflessione sul taglio alchemico del seno della madre così: “Jack lo Squartatore lo ha fatto, alla lettera, pigliando come madri cinque (o sette?) disgraziate donne malandate e affamate, spinto da un bisogno indegnamente alchemico di frugare nella materia prima e nel caos universale. Non era un adepto; una discesa puramente simbolica nel cuore della materia non l’avrebbe attirato. Il parallelismo resta impressionante: quel che gli spirituali fanno figuratamente, in modo incruento, senza dare la morte però vivendola e assorbendola nel proprio essere, il misterioso assassino del 1888 ha compiuto per strade visibili, orribilmente, materialmente. Sopraffatto dalla nigredo ha cercato pace, alla fine, nelle acque nere di un fiume, ultima discesa nel caos. Anche il Black Cat di Poe può suggerire qualche immagine alla ripperologia metafisica: Jack apre i corpi per murarci il Gatto Nero che l’ossessiona; il gatto ancora miagola per le vie di Londra, nel silenzio dei corpi.”
La ricerca del Jack di von Trier è quindi quella – anche accidentale – dell’omicidio sia come speculazione filosofica sulla materia e sul caos, sia ricerca dell’opera d’arte; una teoria, quest’ultima, già teorizzata ne L’assassinio come una delle belle arti da Thomas de Quincey: un nome che ultimamente rimbalza spesso al cinema, vedi il remake di Suspiria.
Il film è brutale, cinico, e anche se non eccede nel gore più efferato non lascia spazio all’immaginazione: è didascalico nella sua pedagogia abietta. Matt Dillon è parecchio convincente nel ruolo dello psicopatico che finge di provare emozioni, “Mr sophistication”, e così il suo grillo parlante Verge/Bruno Ganz.
L’obiettivo è quello di stipare in un cinema/deposito più cadaveri possibili: non solo quelli della cella frigorifera di Jack, ma come in Nymphomaniac ogni suggestione analogica sulla cultura occidentale, lì nel sesso, qui nella mattanza. Si passa così da immagini e citazioni di Blake e Speer, delle diverse fermentazioni dell’uva e Glenn Gould, fino allo stesso cinema di von Trier – un terreno, questo del cinema “multimediale”, su cui Greenaway e Godard sono arrivati già anni fa: von Trier prende ispirazione da allievo diligente.
Tutte le citazioni non sono gratuite: al contrario, The house that jack built è una riflessione terrificante su un mondo visto in negativo, come quella quercia di Goethe che si erge al centro di un campo di concentramento: il simbolo di una purezza guastata da un mondo marcio, irreparabile, perso da sempre.
Lars von Trier non è mai stato un allegrone: va detto che con coerenza la sua strada per l’inferno se la sta lastricando senza mai smentirsi e senza nessuna buona intenzione, dritto dritto nella traiettoria verso un punto di non ritorno, con un ghigno ben stampato in faccia.
Il film è brutale, cinico, e anche se non eccede nel gore più efferato non lascia spazio all’immaginazione: è didascalico nella sua pedagogia abietta. Matt Dillon è parecchio convincente nel ruolo dello psicopatico che finge di provare emozioni, “Mr sophistication”, e così il suo grillo parlante Verge/Bruno Ganz.
L’obiettivo è quello di stipare in un cinema/deposito più cadaveri possibili: non solo quelli della cella frigorifera di Jack, ma come in Nymphomaniac ogni suggestione analogica sulla cultura occidentale, lì nel sesso, qui nella mattanza. Si passa così da immagini e citazioni di Blake e Speer, delle diverse fermentazioni dell’uva e Glenn Gould, fino allo stesso cinema di von Trier – un terreno, questo del cinema “multimediale”, su cui Greenaway e Godard sono arrivati già anni fa: von Trier prende ispirazione da allievo diligente.
Tutte le citazioni non sono gratuite: al contrario, The house that jack built è una riflessione terrificante su un mondo visto in negativo, come quella quercia di Goethe che si erge al centro di un campo di concentramento: il simbolo di una purezza guastata da un mondo marcio, irreparabile, perso da sempre.
Lars von Trier non è mai stato un allegrone: va detto che con coerenza la sua strada per l’inferno se la sta lastricando senza mai smentirsi e senza nessuna buona intenzione, dritto dritto nella traiettoria verso un punto di non ritorno, con un ghigno ben stampato in faccia.
Nicola Laurenza